
Giorgio de Chirico, Autoritratto in costume del Seicento, 1947, La Galleria nazionale, Roma
Oggi Vincenzo Pernice ci presenta l’evoluzione del pictor optimus tra anni Venti e Quaranta: una storia scandita da polemiche, nature morte, autoritratti in costume.
Nell’immaginario collettivo, il nome di Giorgio de Chirico è indissolubilmente legato alla scuola metafisica. Le sue piazze d’Italia e i suoi manichini sono tra le icone del XX secolo. Ma la carriera del pittore è segnata da evoluzioni, svolte, ripensamenti sopravvenuti talvolta in maniera sorprendente, tracciando un itinerario che è stato paragonato a quello del camaleontico Picasso.
Se esiste un fil rouge nel percorso dechirichiano, questo è costituito dal confronto con la tradizione, un concetto che l’artista tenderà a interpretare in maniera sempre più elastica. Accade quindi che il Seicento, dapprima disprezzato, sarà destinato a svolgere un ruolo di primo piano nella sua produzione matura. Gli effetti dell’intensa riflessione critica e storiografica sul Barocco agli inizi del Novecento si misurano, così, anche attraverso l’arte contemporanea.
Contro le mode
Non fu subito amore. Nel 1921, gli addetti ai lavori discutono dei preparativi per la Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento, inaugurata al Palazzo Pitti di Firenze l’anno seguente. A quel tempo, de Chirico è tra gli animatori di Valori plastici. La rivista romana, improntata a un programma di ritorno all’ordine più antifuturista che propriamente antiavanguardista, elegge a modello i primitivi e i precursori del Rinascimento, la cui idealizzazione (quasi geometrica) dei volumi ispira molta della pittura metafisica.
In un articolo intitolato La mania del Seicento, de Chirico critica aspramente quello che definisce “il secolo meno italiano della nostra pittura, il secolo che segnò l’inizio di quella decadenza di cui oggi vediamo le funeste conseguenze”:
Il pittore non cerca più, ha perduto l’istinto del viaggiatore e dell’esploratore. L’eredità che gli hanno lasciato i maestri passati, i padri, i nonni e i bisnonni, gli ha dato una certa faciloneria nel dipingere; ma questa eredità ammucchiata con tanta fatica dagli avi egli la spreca stupidamente, deturpandola; e cerca di sfruttare il trucco, il giochetto del contrasto violento e stende sulla pittura il crepuscolo del chiaroscuro. Il problema della composizione, concepita nel suo senso spirituale, il problema del modo con cui deve figurare l’apparizione dipinta nel quadrato ο nel rettangolo della tela, non lo tormenta più […]. Nasce così il verismo le cui deplorevolissime conseguenze specie nel nostro paese risultano oggi palesi a quanti hanno occhi puliti e mente chiara.
Da qui, sostiene l’articolo, deriverebbe la facilità di comprensione della pittura barocca, talmente priva di complicazioni da confarsi al gusto borghese di inizio Novecento, alimentando le speculazioni di mercato. Così viene spiegata la moda del Seicento. E dove c’è moda, per Giorgio, non c’è arte.

Valori plastici, a. III, n. 3, 1921
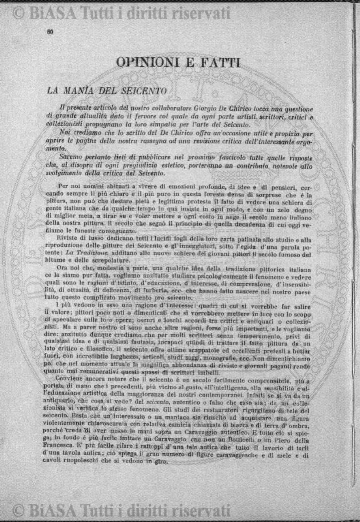
Giorgio de Chirico, La mania del Seicento
Novecento sedotto

Giorgio de Chirico, L’incertezza del poeta, 1913, Tate modern, Londra
L’esposizione di Palazzo Pitti ha un impatto enorme sulla pittura italiana tra le due guerre. A partire da tale occasione, come documentato dalla mostra Novecento sedotto (Villa Bardini, Firenze, 2011), sempre più artisti volgono lo sguardo al XVII secolo, alla ricerca di nuove modalità di rappresentazione della realtà. Insieme a Primo Conti, Achille Funi, Gregorio Sciltian, c’è anche de Chirico tra gli stregati dal Barocco.
Dopo la visita a Firenze, Giorgio cambia radicalmente idea sul Seicento. Il ripensamento è agevolato da circostanze accidentali. Valori plastici chiude i battenti proprio nel 1922. Sciolto da qualsiasi militanza o programma, il pittore è libero di elaborare un nuovo sistema estetico, all’insegna di una concezione ampia di tradizione, ormai pronta a inglobare il Barocco. Lo testimoniano alcuni dei soggetti maggiormente frequentati negli anni Venti.
Se nella serie dedicata alle ville romane è possibile scorgere un’atmosfera sospesa simile a certe vedute sei-settecentesche, l’evoluzione della natura morta dechirichiana è ancor più eloquente. Il genere era stato ampiamente praticato negli anni metafisici con esiti stranianti: gli accostamenti inconsueti di squadrette e strumenti da lavoro, frutta, dolci, frammenti di sculture classiche hanno spianato la strada al surrealismo. Adesso, invece, l’artista elabora composizioni ispirate alle vanitas, secondo l’iconografia tradizionale. In un dipinto come Il bicchiere di vino (1923), il gioco intellettualistico dei significati ermetici cede il posto a una simbologia più convenzionale, non per questo priva di stimoli sotto il profilo esegetico.

Giorgio de Chirico, Il bicchiere di vino, 1923, collezione privata
Nel segno di Rubens
Con la pubblicazione del Piccolo trattato di tecnica pittorica (1928), de Chirico dichiara la necessità di riportare al centro la perfezione formale, intesa come perizia artigianale. La riflessione sulla pennellata e sulla composizione delle paste pittoriche passa attraverso lo studio dei maestri. Negli anni Quaranta, fiamminghi e spagnoli sono in cima alle preferenze di Giorgio, con particolare riferimento a Rubens, Velázquez, Ribera, ma il canone personale si estende fino al Rococò con Watteau.
Soprattutto di Rubens, definito “maestro tra i maestri”, de Chirico realizza numerosi studi e copie, mentre la sua produzione originale accoglie sempre più autoritratti, ironiche rappresentazioni dal sapore teatrale. Il riferimento al Barocco è contenutistico oltre che formale: cappelli piumati, tenute da torero, costumi seicenteschi formano i mascheramenti di un artista classico per scelta, perché intenzionalmente fuori dal tempo.
Giorgio de Chirico, copie e studi da Pieter Paul Rubens
Dapprima osteggiato, il Seicento è diventato una componente essenziale del repertorio dechirichiano, merito anche delle rivalutazioni coeve in sede critica ed espositiva. Va però rilevato un problema: i riferimenti barocchi dell’artista, almeno quelli espliciti, sembrano essere perlopiù stranieri, in molti casi avallati da una consolidata fortuna critica. Lo stesso avviene per diversi suoi colleghi, attratti più da Vermeer e Velàzquez che non da Reni o i Carracci. Per il momento, insomma, un più ampio apprezzamento della pittura italiana del Seicento è rimandato alla mostra di Caravaggio del 1951. Da allora sarà un’ascesa inarrestabile.














